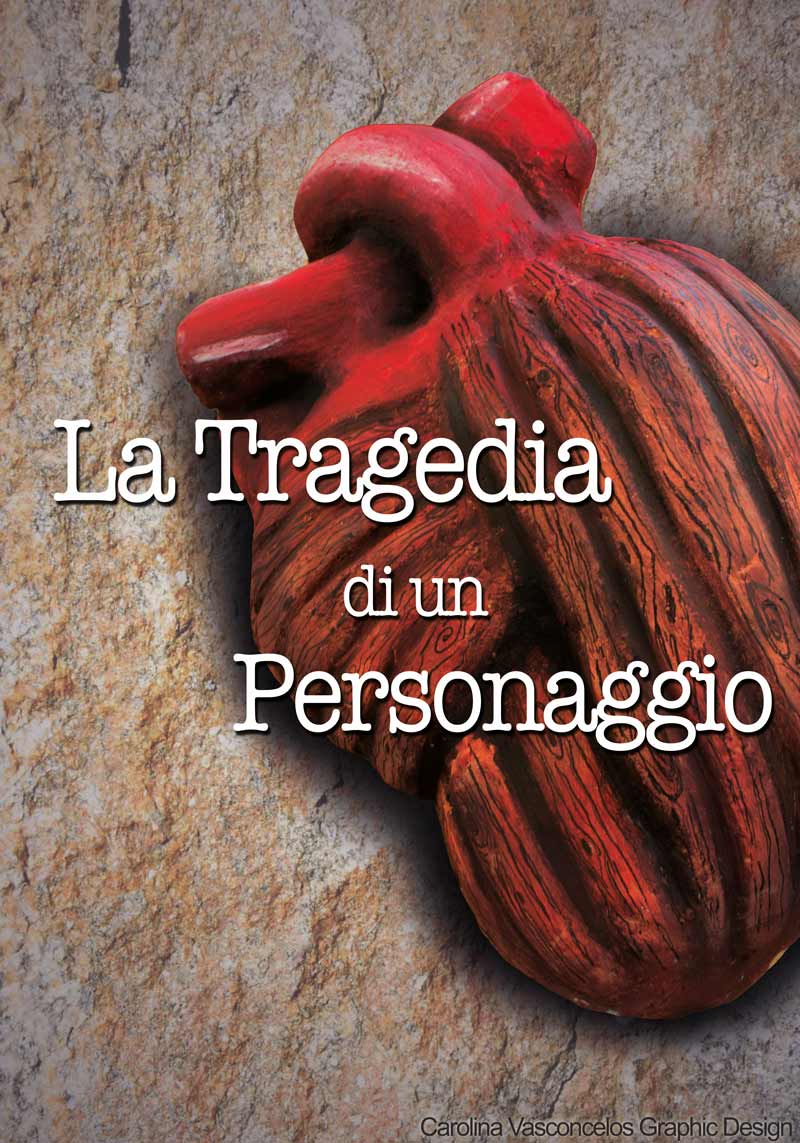con
Irene Ientile – Voce
Nicola Mogavero – Sax
Marcella Napolitano – Viola e Violino
Ornella Cerniglia – Piano e Synth
Gianluigi Cristiano – Chitarra Elettrica e Basso Elettrico
Simona Malato – Voce Recitante
Silvia Giuffré – Coreografie
con
Giuseppe Rizzo
Suono e Soundscape
Petra Trombini
Luci
“Non più parole e nomi; distinguo soltanto certi suoni; – un candeliere d’argento o un vaso di cristallo risuona da solo e all’improvviso smette facendo finta di niente, come se non avesse risuonato, come se nessuno lo avesse toccato né gli fosse passato accanto.
Un abito da donna si accascia mollemente dalla sedia sul pavimento, spostando l’attenzione dal suono precedente alla semplicità del nulla.”
Ghiannis Ritsos – Elena (1970).

NOTE DI REGIA
GhiannisRitsos nacque nel 1909 a Monemvasià, antica fortezza veneziana nel Peloponneso meridionale, ed è lì che riposa dal 1990, sotto una lapide monumentale, nel minuscolo cimitero della città, scarmigliato dal vento perenne e dagli sbuffi salmastri. Dicono che là, spesso, si notino le strane tracce di un umile bivacco: qualche briciola di pane, un paio di mozziconi di sigaretta, una lattina deformata. Attestano che qualcuno vi si sofferma. I morti sono qui, adesso, tra noi.
“I morti sempre e dovunque sono più numerosi dei vivi. Non parlano –
perciò il silenzio si infittisce. Tuttavia ascoltano;
sentono prima ancora del rumore; sentono i nostri passi
prima che ci alziamo dal letto a prendere
un bicchiere d’acqua dal rubinetto”
I vivi, in netta minoranza, siamo gli eredi di ciò che è stato, testimoni e artefici di un presente che lasceremo in eredità a nostra volta. Ma loro, i morti, sono tutti lì che ci osservano, che sentono i rumori dei nostri passi prima che li facciamo.
Fin dai primordi della civiltà il culto dei morti ha accompagnato l’umanità. Non c’è popolo che non abbia onorato, commemorato, rispettato i defunti: il diverso modo di esprimersi è soltanto manifestazione distintiva per cultura, tradizioni, costumi, religioni. In Sicilia il culto dei morti poco differisce dal tempo degli avi greci e romani che sulle tombe dei loro defunti portavano corone di fiori, pane inzuppato nel vino e dolcetti di miele, mentre tutt’attorno si spargeva farina con un pizzico di sale e si banchettava pure allegramente.
Ma il culto laico che si deve ai defunti sta nella custodia e nella preservazione dell’inestimabile patrimonio culturale che da loro abbiamo ereditato. Siamo i testimoni di ciò che l’umanità ha prodotto, nel bene e nel male, successori e guardiani di tutto, e fino al prossimo passaggio di testimone. Talvolta capita di perdere il controllo di tutta questa eternità, o peggio, che il rispetto e la celebrazione dovuti a ciò che viene riportato alla luce vengano sviliti nell’amministrazione di ciò che nasce e vive nel presente: un teatro viene dissepolto da secoli di oblio, che grande gioia, e contemporaneamente un sistema incapace ne seppellisce degli altri, ogni giorno.
“Il teatro della città antica è stato trovato. È il teatro del periodo ellenistico, si estende a semicerchio con un diametro di oltre 100 metri ed è rivolto verso la Valle dei Templi e il mare. Dal punto di vista topografico, il Teatro costituisce la quinta monumentale con cui l’area pubblica dell’agorà si affacciava verso la Valle dei Templi. Una piazza grande con criteri urbanistici tipici dell’età ellenistica, una delle più ampie del mondo antico con una superficie totale di circa 50 mila metri quadrati, che uguaglierebbe quella di Atene.”
Un teatro viene riportato alla luce, alla vita, insieme ai personaggi, agli autori, i miti e gli eroi che hanno attraversato gli inferi e i secoli per tornare a raccontare le loro gesta, ma niente potrà più essere come prima, gli antichi splendori, le battaglie, le sconfitte, le vittorie, le glorie, i fasti, sono echi di un’epoca lontana, troppo lontana, metafora della condizione culturale dell’età contemporanea.
Akragas Capitale del Mondo Antico e Patrimonio dell’Umanità,Ubi Ensembleprende spuntodal recente ritrovamento del Teatro Ellenistico della Valle dei Templi di Agrigento, per celebrare il sistema-polis, con la sua agorà, cuore pulsante della vita dei cittadini, in cui case, mercati, templi e teatri sono espressione imprescindibile di una città minima. Ovunque ci siano case, mercati, templi e teatri, lì vi sarà una città, ove manchi una sola di queste entità, non si potrà parlare di città, né di cittadini.
I morti – anche i personaggi di teatri dissepolti, i morti per eccellenza, che vivi non furono mai se non nella mente dei loro autori, anche loro – più numerosi dei vivi, tornano a calcare il palcoscenico di un teatro dimenticato da tutti, per mettere in scena questa lezione civica, la più severa.L’Elena di GhiannisRitsos (1970) è figlia di questi tempi, e vuole essere l’incarnazione dellariflessione su questo tema.
“Grosse verruche mi sono spuntate sul viso. Grossi peli intorno alla bocca – li tocco; non mi guardo allo specchio – peli ispidi, lunghi, – come se qualcun altro si fosse installato dentro di me,
un uomo sfrontato, malevolo, la cui barba
spunta dalla mia pelle.”
Quest’Elena viene alla lucecon la suastoria dissepolta, per rappresentare l’urgenza del tempo che fugge, metafora che ben si attaglia alle grandi riflessioni dell’età contemporanea. Ci appare in una veste inquietante, al limitare della sua vita, non c’è più traccia sul suo corpo dell’antica bellezza.
In quest’ottica va letta La Tragedia di un Personaggio: Elena, e il suo immaginario interlocutore che stenta a riconoscere la figlia di Zeus “che alle dee immortali terribilmente somiglia”, sono i personaggi della storia del quotidiano di ognuno di noi,che si muovono a stento tra la sedia e il letto in una casa polverosa che sa ineluttabilmente di morte.
“In questa casa il vento si è fatto pesante e inesplicabile, forse per la presenza così naturale dei morti.”
Nella stanza – ospizio per lungodegenti – la vecchia vede l’uscita dal proprio corpo come una liberazione. Elena disvela la propria identità, a poco a poco, attraverso gli spunti offerti dagli oggetti che la circondano, e che risvegliano la sua memoria, in una serie di folgoranti flashback. Ricordi, i suoi, avari, stentati, maligni, dai quali riemergono faticosamente i nomi “più familiari” degli eroi greci, che essa confonde:
“Ora dimentico i nomi più familiari o li confondo tra di essi – Paride, Menelao, Achille, Proteo, Teoclimeno, Teucro, Castore e Polluce…”
Ed è una lunga agonia senza gloria, quella che racconta Elena, una storia che si replica inesorabile nella tragedia della storia contemporanea del Teatro, della Polis, dell’Agoràin cui viviamo oggi, in cui la morte è una liberazione solo se avviene per ascensione, per sublimazione,che però è solo presunta,
E quella scena, sopra le mura di Troia, – che fossi davvero ascesa al cielo
lasciandomi cadere dalla bocca – ? A volte mi avviene ancora di provare,
distesa qui sul letto, ad aprire le braccia, a camminare
sulle punte dei piedi – a camminare in aria – il terzo fiore -“
sfocata immagine nei vaghi ricordi di Elena, che, per questa ragione,consegna a noi il testimone, eredi della sua storia, per scriverne un finale diverso, inequivocabile, più rassicurante, utopia di un teatro quotidiano, di quartiere,
“con gli stucchi del soffitto staccati, coi muri scalcinati,
con un immenso sipario rosso stinto, calato, […]
mentre giù in platea lampadari e applausi sono spenti da tempo […]
in cui l’uomo contemporaneo recita ogni giorno la propria esistenza, cercando di scrutare lontano, alzando gli occhi al cielo,per provarea mettere a fuoco la reale sostanza delle cose.